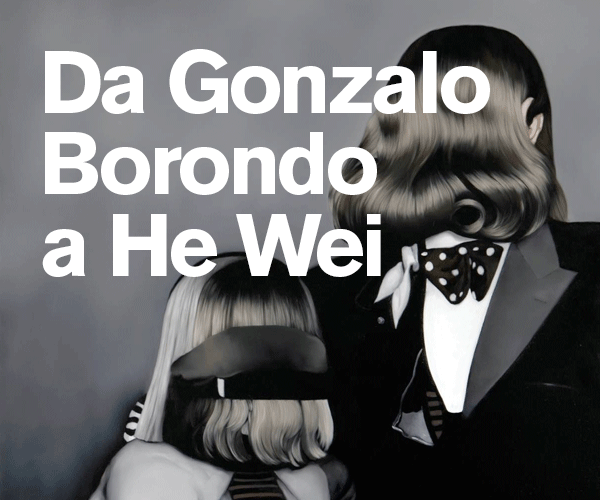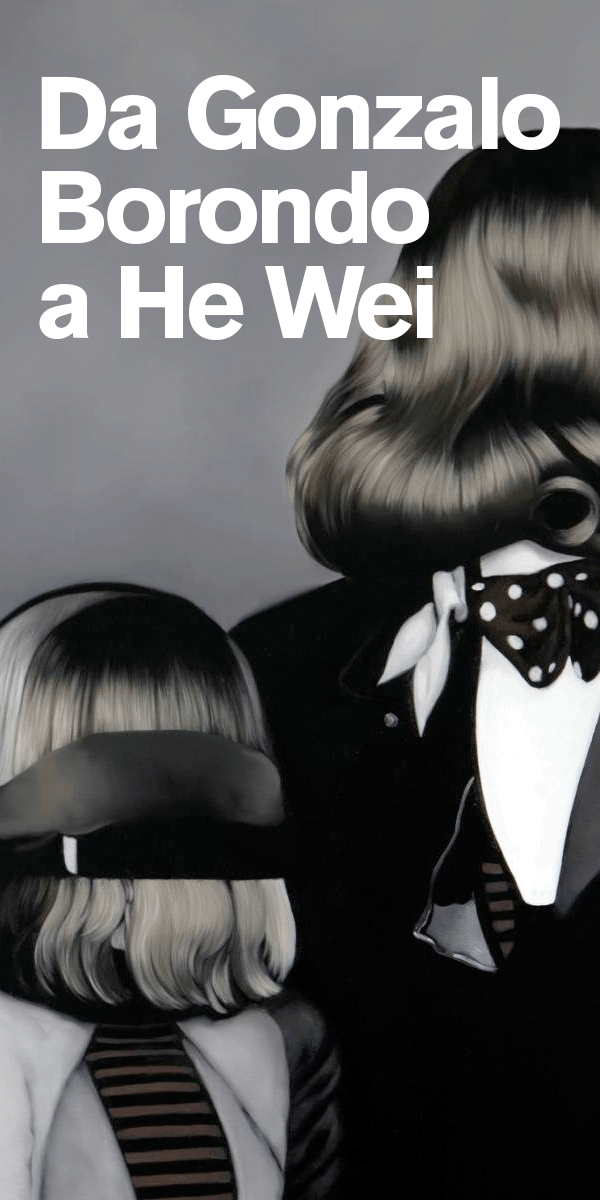Ultimora
30 Jan 2026 12:51
Stefani inaugura il nuovo Ospedale di Comunità a Bassano
30 Jan 2026 12:50
Alle Gallerie dell'Accademia i segreti della 'Genesi' di Tintoretto
30 Jan 2026 12:15
Andrea Martella è il candidato sindaco di Venezia del centrosinistra
30 Jan 2026 11:41
Comprati 3 milioni in meno di libri nel 2025, flessione del 3% sul 2024
30 Jan 2026 13:10
Alla scoperta di I peccatori, Secret Love e Sandokan
30 Jan 2026 13:00
++ Trump nomina Warsh a capo della Federal Reserve ++
30 Jan 2026 13:03
Trump nomina Warsh a capo della Federal Reserve
 Laura Vicenzi
Laura Vicenzi
Giornalista
Bassanonet.it
Adolescenza: un'età fragile, a volte interrotta
La nostra intervista al neuropsichiatra Stefano Vicari, ospite giovedì 18 settembre, in Sala Martinovich, dell'appuntamento conclusivo di Connessioni contemporanee
Pubblicato il 13-09-2025
Visto 4.667 volte
C’è una parola che ricorre sempre più spesso quando si parla di giovani: fragilità.
Ma dietro a questo termine – a volte usato con leggerezza, altre con preoccupazione – c’è un mondo complesso che riguarda salute mentale, contesti educativi, attese sociali, solitudini silenziose.
Il 18 settembre, per il terzo e ultimo appuntamento della rassegna Connessioni contemporanee, Stefano Vicari, professore ordinario di Neuropsichiatria Infantile alla Cattolica e primario al Bambino Gesù di Roma, il più grande Policlinico e Centro di ricerca pediatrico in Europa, incontrerà il pubblico di Bassanonet in Sala Martinovich per parlare di adolescenza, benessere e salute mentale. Un dialogo ispirato anche dal suo libro Adolescenti interrotti, pubblicato nel 2025 da Einaudi, già apprezzato riferimento per chi lavora – o vive – a contatto con le nuove generazioni.

le dinamiche giovanili, tra problematiche, sfide e opportunità, al centro del terzo incontro di Connessioni contemporanee
Non una lezione dai risvolti puramente professionali, legati all’ambito medico, ma un confronto aperto e necessario, quello proposto all’interno del nostro ciclo di incontri, perché i dati parlano chiaro: ansia, depressione, disturbi del comportamento e della condotta alimentare sono in forte aumento, e la pandemia che abbiamo attraversato tutti, i giovani però in una fase preziosa per la costruzione dell’identità e di assetti di equilibrio, ha accelerato dinamiche già sorvegliate speciali da tempo. Stefano Vicari è tra i professionisti della salute che si pongono in ascolto e provano a ricostruire con tanti ragazzi la fiducia nel futuro. Come dichiara nel suo libro: se li ascoltiamo davvero, i ragazzi sanno salvarsi.
L'incontro sarà moderato da Alessandro Tich, direttore di Bassanonet.
A intervenire in un momento di dibattito, al termine del contributo dell’ospite d’onore, saranno: Irene Bagnara, educatrice che fa capo alla Cooperativa Adelante e a Rete Pictor; Sergio Contin, tecnico della nazionale olimpionica di triathlon nel 2012 e nel 2016; Alessandro Cortiana, psicanalista membro del Rotary Club Bassano Castelli; Federico Piotto, attivo nel panorama culturale della Valbrenta con l’associazione Veneto Barbaro.
Contin e Piotto saranno anche ospiti di un podcast di Radio Voice, mediapartner della rassegna, per alcuni approfondimenti legati alle dinamiche giovanili viste in connessione con il territorio, all'interno del mondo culturale e dello sport.
La nostra intervista al professor Vicari.
Professor Vicari, il titolo del suo libro è chiaro e diretto: “Adolescenti interrotti”. Cosa viene interrotto in loro e da che cosa?
Una qualunque sofferenza psicologica, sia che assuma i connotati di un vero e proprio disturbo o meno, interferisce fortemente sulla qualità di vita di ciascuno, soprattutto dei più giovani. I ragazzi che presentino un disturbo d’ansia, o una depressione, vivono in modo meno “fluido” la propria crescita, la propria adolescenza. La loro età è come se venisse interrotta, in termini di qualità, di relazioni, di conoscenza, di esperienze che si possono realizzare. Non uso il termine “spezzati”, ma “interrotti”, perché generalmente se questi disturbi vengono affrontati, trattati, gestiti, se ne esce, e la vita continua a scorrere con la sua complessità, ma con serenità.
Per molti ragazzi, quello di difficoltà può essere un periodo, più o meno ampio, e riconoscerlo in tempo ci consente di riprendere positivamente il corso di una vita che merita di essere vissuta. Se parliamo di un semplice malessere, un’attenzione particolare da parte del contesto che circonda il ragazzo (famiglia, scuola, mondo delle relazioni) può essere sufficiente, se parliamo di un disturbo strutturato, l’intervento di un operatore della salute mentale diventa indispensabile, intendo uno psicologo o un neuropsichiatra infantile, dipende molto dalla gravità che il disturbo stesso assume per esprimersi.
Si dice spesso che i giovani oggi siano più “fragili” rispetto alle generazioni precedenti. Lei è d’accordo?
Sappiamo da ciò che affermano le neuroscienze che l’adolescenza da sempre è un periodo caratterizzato da una forte fragilità, e questo perché il cervello assume una forte spinta alla maturazione, vanno a compimento una serie di circuiti e di regioni cerebrali che sono quelle che mediano molto l’autocontrollo – nel bambino sono soltanto abbozzate. Si stima che l’adolescenza biologica si compia intorno ai 25 anni. Una fragilità è insita in questa età. È come dire che la vecchiaia sia un’età fragile dal punto di vista della salute soprattutto fisica.
La salute mentale nell’adolescenza è a rischio. Molto dipende da fattori ambientali, che possono amplificare questo rischio, o contenerlo e ridurlo. Assistiamo oggigiorno a un forte aumento delle forme di dipendenza, che forse altre generazioni hanno conosciuto di meno, magari quelle passate hanno avuto altri problemi: la mia ha conosciuto quella dell’eroina, che sta prepotentemente tornando; quella dei miei genitori ha avuto quella dell’alcool. Però oggi le forme di forme dipendenza sono molto più subdole, diffuse, abbordabili, perché la rete ha reso tutto più immediato e prossimo fino dall’età più precoce: la dipendenza da sostanze, i cannabinoidi in particolare, ma anche le dipendenze comportamentali, in primo luogo la dipendenza da internet, un fenomeno del tutto nuovo che spiega il sensibile aumento di malattie mentali diffuse tra i bambini e i preadolescenti.
L’adolescenza è quindi un momento di fragilità, il che non significa sia brutta o che tutti gli adolescenti siano malati. Vi è comunque attualmente un 20% della popolazione infantile e giovanile, e non è poco, che presenta un disturbo mentale. Guardiamo al fatto che i fattori di rischio, le forme di dipendenza, sono aumentati, e contemporaneamente stanno diminuendo le protezioni: il ruolo della famiglia, in termini di comunità educativa, è in difficoltà; la scuola, intesa come luogo di aggregazione, di condivisione di spazi, di emozioni e di pensiero è in sofferenza, laddove vada troppo verso modelli di competizione e selezione. Il merito va valorizzato, lo prevedono i principi costituzionali, ma la scuola è soprattutto “per tutti”. Come diceva Don Milani, se accogliessimo a scuola solo chi non ha problemi è come se ricoverassimo in ospedale chi è sano.
Come società, dobbiamo rivolgerci soprattutto a chi vive grandi difficoltà sociali, culturali. C’è intorno una povertà non solo economica, ma culturale sempre più diffusa nel nostro Paese: una povertà di valori, di conoscenze, la perdita del piacere di sapere.
Quali sono le principali richieste d’aiuto che arrivano attualmente ai servizi di neuropsichiatria infantile a cura dei famigliari, o delle istituzioni?
Dal 2010 a oggi abbiamo registrato un aumento del 500% delle richieste di emergenza. Se quindici anni fa arrivavano al Pronto Soccorso circa 230 ragazzini l’anno con un problema acuto di tipo psichiatrico, adesso ne arrivano 1800. Nella stragrande maggioranza, sei volte su dieci, si tratta di casi di autolesionismo: si tagliano, si fanno del male, tentano di uccidersi. Per lo più, alle spalle di questi atti c’è una depressione, un disturbo dell’umore. I motivi più frequenti dell’accesso sono dunque la depressione, l’8%, e l’ansia, il 4%. Ma non vanno sottovalutati, in quanto sono cresciuti notevolmente, i disturbi alimentari, in particolar modo l’anoressia, che rappresenta uno dei grandi motivi di accesso al Pronto Soccorso. Quarto l’elemento, poi, le crisi di agitazione, ovvero l’incapacità di gestire la rabbia, gli agiti violenti, l’aggressività che molti ragazzi fanno fatica a controllare. In diversi casi queste crisi hanno risvolti drammatici, richiedono un intervento sanitario.
I genitori: la loro una reazione spesso da “non vedo non sento non parlo”, eppure quasi sempre attori se non protagonisti quanto meno comprimari, nell’insorgenza di stati di disagio psichico nei ragazzi.
Tra i disturbi mentali, ansia e depressione sono fenomeni complessi che raramente riconoscono un solo fattore determinante, per capirci, un po’ come accade per l’infarto del miocardio, o il cancro al colon, vi è una compartecipazione di più cause a determinare il manifestarsi di un disturbo. I genitori raramente sono di per sé la causa ultima del disturbo mentale, possono invece essere molto spesso l’elemento di cura, di aiuto, per i loro ragazzi.
Certo, generalizzando, i genitori oggi fanno molta fatica ad accorgersi di alcune cose, perché il nostro modello di organizzazione famigliare è molto cambiato negli ultimi decenni. I ragazzini spesso a casa non hanno nessuno, i nonni rappresentano una grande risorsa per le famiglie e un’importante fonte di affetto, ma non sempre riescono a essere una presenza educante.
I genitori a volte sono distratti anche perché in diversi casi rincorrono l’adolescenza dei loro figli, cioè faticano ad accettare l’idea che sono meno giovani di quanto si sentano: la vita si allunga, il sessantenne di oggi somiglia più al quarantenne di vent’anni anni fa che al sessantenne di allora. L’aspettativa di vita, ma anche l’efficienza fisica raggiunta ci porta a fare fatica a farci da parte di fronte ai ragazzi, e quindi a lasciare che siano loro stessi ad assumersi delle responsabilità. Questo impatta sulla salute mentale degli adolescenti.
Essere distratti non ci fa accorgere dei segnali del disagio, di richieste di aiuto. Quando se ne accorgono, i genitori sono spesso spaventati, perché c’è sempre il pregiudizio che la colpa delle difficoltà di un figlio sia da attribuire a una cattiva genitorialità, e quindi ci si illude piuttosto che il problema non esista, che la crisi col tempo passi da sola, si pensa che il problema non vada ingigantito; in diversi casi inizia una fase di accuse reciproche all’interno della coppia genitoriale che distoglie attenzione, tempo ed energie.
Nel suo libro scrive che “gli adolescenti non vogliono fuggire dalla realtà, ma smettere di soffrire”. Quali accorgimenti mettere in atto, per aiutarli ad affrontare il dolore che sentono, e non sanno dire?
Per aiutarli bisogna innanzitutto stare con gli occhi bene aperti. I figli vanno controllati, soprattutto al giorno d’oggi, dove a 9-10 anni alcuni bambini hanno già il cellulare. Si deve sapere che siti frequentano, che messaggi ricevono: vanno protetti rispetto al mondo esterno, reale e virtuale.
Si assiste oggi a un fenomeno un po’ bizzarro: i genitori sono molto attenti a non esporre a pericoli che si pensa comporti ad esempio l’andare a scuola da soli, o fare in autonomia piccoli acquisti. Davanti alle scuole al mattino, all’orario d’ingresso, c’è un traffico impressionante, pochi ragazzi si muovono a piedi, o in bicicletta. Vi è invece poco controllo, anche in età molto precoce, su cellulari e device usati in libertà, con accesso libero alla rete. Anche per questo, l’educazione sessuale tanti ragazzini prima che a scuola la fanno su siti per adulti.
I genitori dovrebbero preoccuparsi molto dei messaggi che arrivano loro, che quasi mai sono neutri, gratuiti, hanno spesso un significato ben preciso. Gli schermi creano una dipendenza forte: raccontano storie e fanno vedere immagini che spesso i bambini non sono in grado di comprendere e di metabolizzare.
Bisogna esserci, educare, dedicare una qualità del tempo piacevole ai propri figli, divertente per tutti. E, importantissimo, dare regole: i genitori non devono essere degli “amici”, ma essere coloro che dicono dei no, i no necessari. I nostri figli dovranno metaforicamente piano piano “farci fuori” come autorità, fa parte dei meccanismi della crescita, ma noi dobbiamo sempre essere un punto di riferimento per loro.
Il 30 gennaio
- 30-01-2025Ma…ffioli
- 30-01-2024Rito allungato
- 30-01-2020Ti racconto una Storia
- 30-01-2017Il Brutto Anatroccolo
- 30-01-2017Ladro over 60 nella rete dei CC
- 30-01-2016Vuoto a rendere
- 30-01-2015Abbandono di Stato
- 30-01-2015Funerali don Armido, a Rosà il lutto cittadino
- 30-01-2014Nasce il Tavolo di Marketing Territoriale “Territori del Brenta”
- 30-01-2013A Rosà i candidati PD: “Chi siamo e cosa faremo”
- 30-01-2013La scelta di Kaoutar
- 30-01-2013L'Eco dalla Laguna
- 30-01-2012Nuova Valsugana a Romano: il sindaco pubblica le carte
- 30-01-2010Conclusa a Romano d'Ezzelino l'“Operazione amianto”
- 30-01-2010Annullate le “Torri”, il Pdl ricorre dal prefetto
Più visti
Politica
24-01-2026
‘è IL MOMENTO’: Gianfranco Cipresso alla guida del nuovo direttivo
Visto 9.007 volte
Attualità
24-01-2026
Chatbot e cittadini: istruzioni per l’uso al Palazzo del Doglione
Visto 8.536 volte
Attualità
24-01-2026
Da febbraio, attesi in Libreria AperiLibro e il Club Bassanese
Visto 8.531 volte
Geopolitica
27-01-2026
Gran Bretagna – Cina: svolta nelle relazioni bilaterali con l’approvazione della mega ambasciata cinese a Londra
Visto 8.404 volte
Attualità
16-01-2026
Il 'The Times' incorona il Veneto: siamo noi la regione da visitare (impalcature comprese)
Visto 17.838 volte
Attualità
16-01-2026
La Fiamma Olimpica a Bassano: mercoledì 21 il passaggio sul Ponte Vecchio
Visto 14.338 volte
Geopolitica
05-01-2026
La Danimarca acquista missili dagli Stati Uniti nonostante le pretese di Trump sulla Groenlandia
Visto 11.731 volte
Politica
12-01-2026
«Narrazioni da romanzo e visibilità personale»: esplode il caso Polizia Locale
Visto 9.722 volte