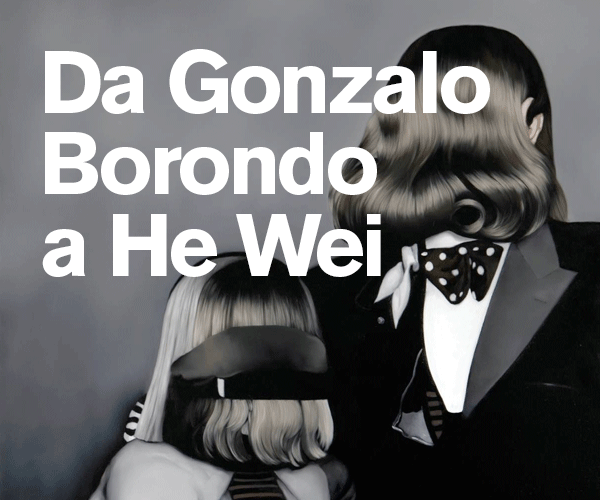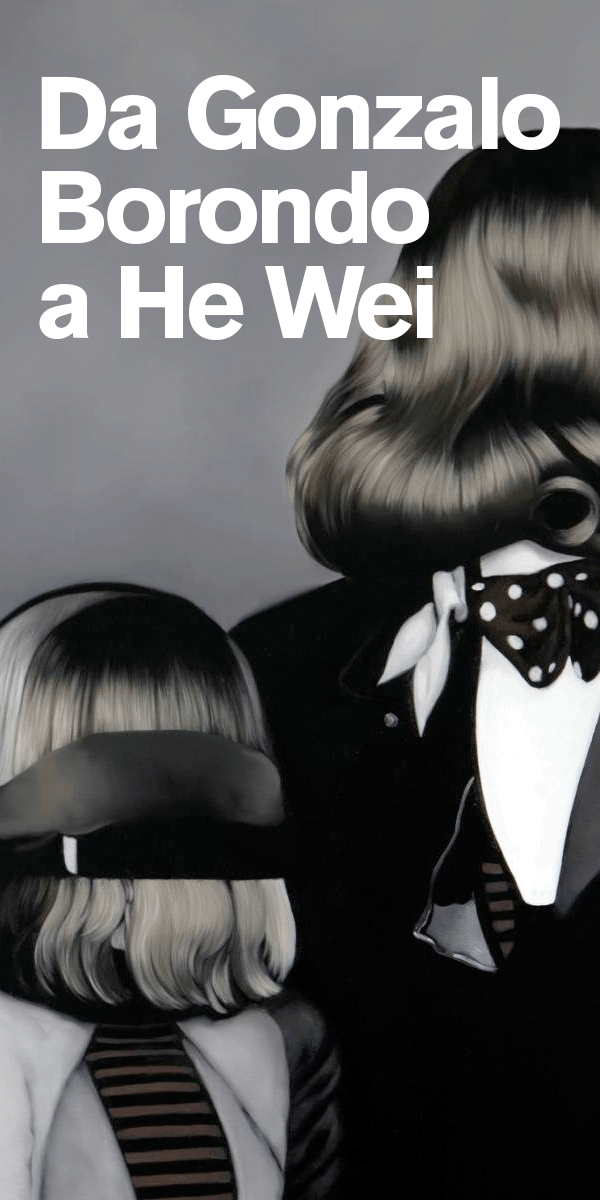Ultimora
14 Jan 2026 20:44
Esplode un ordigno bellico, muore un collezionista
14 Jan 2026 17:42
Etruschi e Veneti, 750 reperti in mostra a Palazzo Ducale a Venezia
14 Jan 2026 17:16
Giovane scomparsa, le telecamere la riprendono con bici e zainetto
14 Jan 2026 16:00
Trentini ancora lontano dal Lido, la madre attende il rientro a casa
14 Jan 2026 15:48
Milano Cortina -23: Thoeni 'dovrei essere tra gli ultimi tedofori, magari sciando'
14 Jan 2026 15:32
Camion si rovescia per evitare frontale e schiaccia furgone, un morto
15 Jan 2026 08:45
Tajani: "Libero in Venezuela Luigi Gasperin"
15 Jan 2026 08:24
++ Tajani, libero in Venezuela Luigi Gasperin ++
15 Jan 2026 07:59
PRIME PAGINE | Trump pronto all'attacco, "vediamo cosa fa l’Iran"
15 Jan 2026 07:15
X annuncia misure per impedire a Grok di spogliare persone reali
15 Jan 2026 07:07
Ancora tensioni a Minneapolis, un agente spara e ferisce un immigrato
 Laura Vicenzi
Laura Vicenzi
Giornalista
Bassanonet.it
Bene o male, il mondo in serie dei nuovi detective
La nostra intervista a Jacopo Bulgarini d'Elci, primo ospite con Livio Pacella, giovedì 4 settembre in Sala Martinovich, di Connessioni contemporanee
Pubblicato il 25-08-2025
Visto 4.627 volte
Quella seguente è l’intervista che abbiamo rivolto a Jacopo Bulgarini d’Elci, progettista culturale, fondatore e direttore di Mondoserie.it, protagonista con l’attore Livio Pacella, collaboratore storico del sito, del primo incontro di Connessioni contemporanee giovedì 4 settembre, in Sala Martinovich (ingresso libero previa prenotazione: connessionicontemporanee.it).
L’appuntamento, attraverso immagini, parole, letture d’autore, getterà uno sguardo alle serie tv e in particolare all’evoluzione nel tempo della figura del detective, rapportata “oltre la fiction” al nostro presente. Seguirà un momento di dibattito condotto da Alessandro Tich, direttore di Bassanonet, con ospiti, oltre ai relatori: Flaviano Bosco, Giovanni Cunico e Romano Zanon.
Qui, l’articolo che ha preceduto e introdotto la conversazione: shorturl.at/AbDTk.

da True Detective
Nei classici di Conan Doyle, Agatha Christie o Simenon, l’investigatore non era solo un personaggio centrale, ma colui che sa vedere dove gli altri non vedono, collega ciò che appare disgiunto, decifra i segni del caos. La fiducia vacilla? Il disordine non è un ostacolo alla verità, ma la sua condizione permanente?
Per prendere in esame in modo approfondito l’evoluzione della figura del detective, è utile rivolgere l’attenzione alla matrice letteraria da cui trae origine. Guardando lontano, Edipo ne è il precursore: un indagatore di enigmi messo di fronte a un vero e proprio cold case. Edipo si renderà tragicamente conto, alla fine, di essere egli stesso il colpevole che tanto cercava.
Prima di arrivare a serie tv contemporanee esemplari, come True Detective ad esempio, nella modernità si rivolge lo sguardo all’Inghilterra di fine Ottocento e primi anni del secolo scorso, nel regno della cultura positivista in cui prosperarono progresso tecnologico, scienza, fiducia nella capacità razionale umana. Non a caso nacquero lì personaggi iconici come il mitico Sherlock Holmes ed Hercule Poirot, il leggendario detective belga creato da Agata Christie.
Il genere poliziesco ha sempre avuto un consumo popolare enorme, a cambiare nel tempo è stato il medium narrativo: si è passati dai racconti a puntate sui giornali, alla forma del libro, più avanti a prodotti per la radio, il cinema e la tv. La rappresentazione delle storie “in giallo” parlava di un mondo che tornava a cercare un punto di orientamento rassicurante, il lieto fine. Ma questo modello non funziona più. O meglio, in serie contemporanee come NCIS e CSI si usano ancora gli stessi meccanismi, una sorta di offerta di comfort food televisivo; viceversa, il modello post moderno mette in scena la messa in crisi di certezze, canoni, modalità di esecuzione narrativa e drammaturgica, propone un’idea di mondo dove i detective non risolvono nulla, o gialli che assumono un contorno mistico e metafisico, come accade in Too Old to Die Young.
A questa evoluzione ha contribuito enormemente Twin Peaks, serie iconica che ha provocato uno sfondamento totale del vecchio modello, del quale ha offerto una non troppo ironica parodia. A mio parere, a tutto ciò ha dato inizio l’irruzione nel nostro immaginario della figura del serial killer: c’è qualcuno che racconta una storia folle, allucinante, la sua distorta visione del mondo, e ci si pone in ascolto. Da lì, non c’è ritorno. Anche di questo parleremo alla conferenza, tra parole e immagini, e con il contributo di letture d’autore.
Tante serie recenti e nuove hanno quindi come protagoniste figure che si collocano in un’area liminale, che si espongono al male per cercare di comprenderlo, e ne raramente ne escono illesi. Qualche esempio memorabile?
Tra tanti personaggi interessanti, andando alle figure considerate antesignane, non posso prescindere da indicare il detective di Twin Peaks, ovvero l’agente Dale Cooper. Si tratta di un funzionario dell'FBI metodico e intuitivo, ma da subito spiazzante: dà retta ai sogni, parla con un nano che balla, è affascinato dagli alberi, manifesta un’adorazione per il caffè nero e la torta di ciliegie, registra ossessivo messaggi per Diane, una misteriosa segretaria… Ma soprattutto, il suo all’interno degli episodi è un viaggio in un’oscurità e una doppiezza che gli appartengono. Sempre in tensione, in un alternarsi tra dentro e fuori, la lotta tra bene e male che incarna l’agente Cooper, il “nuovo” detective.
Al termine della terza stagione, realizzata da David Lynch a 25 anni di distanza dalle precedenti, ho avuto occasione di scrivere: «… resta lo smarrimento, resta il dubbio, resta la paura, resta un grido nella notte, resta il buio».
Spesso a dominare è la perturbazione, i casi rimangono irrisolti, o quasi, o conducono a un finale che lascia spazio al dubbio. I mutamenti in tale ambito riguardano solo il contenuto, o anche la forma in cui è espresso?
Vi è stata nel tempo una grande maturazione del medium televisivo. Prima del passaggio nel terzo millennio, i prodotti erano tecnicamente fatti in un certo modo, spesso ben riconoscibile. Lo stile e il linguaggio della narrazione per lo schermo si traducono in tanti elementi, non è solo questione di fotografia, di regia, di montaggio, ma di variazioni d’insieme che modificano la grammatica del racconto. Nella scansione, ad esempio, spesso si nota una commistione di piani temporali.
Diversi autori provenienti dal cinema, pioneristicamente sono stati tra i primi a creare prodotti televisivi. Vi è stato sicuramente in questi contributi un incremento della complessità. Pensiamo a Mindhunter e al dietro le quinte di questa serie, di cui David Fincher è produttore e ha diretto i primi episodi: vi si narra la nascita del FBI profiler, e gli autori si sono basati su profilazioni autentiche di serial killer.
Ci sono poi serie stranianti come quella firmata dal regista danese Nicolas Winding Refn, tra i prodotti d’autore che esamineremo alla conferenza.
In gran parte, siamo esposti a una serialità “all’americana”. Lei è anche l’ideatore dell’Italia-America Friendship Festival, tra pochi giorni a Vicenza. Su quella italiana?
Le serie poliziesche made in Italy sono in gran parte il riflesso della realtà italiana. Ci sono casi di prodotti d’esportazione, penso a La Piovra, Romanzo criminale, e poi a Gomorra, Suburra… Si tratta di un genere ibrido, tra melodramma e crimine organizzato. Il nostro Paese ha un patrimonio di storie affascinanti di matrice gangsteristica.
Stilemi, ricchezza produttiva e narrativa hanno contrassegnato dagli esordi la serialità americana, che continua a produrre le cose più interessanti, ma non c’è solo l’America, si sono ampliati tanti altri mercati: Squid Game, una serie sud coreana, è diventata in un lampo un fenomeno globale; sono molto apprezzate le serie scandinave, quelle britanniche... La maggior parte delle serie di matrice italiana segue il modello della fiction Rai, ma il nostro Paese ha realizzato prodotti di grande qualità, spesso di genere crime o para-criminale.
È ancora possibile, in questo scenario, il ritorno al detective classico? O lo è solo in chiave ironica o nostalgica?
Se si possa tornare indietro non lo so, credo dovrebbe succedere qualcosa di molto drastico nel nostro modo di pensare la società e il mondo. Il giallo, negli ultimi 150 anni, è sempre stato il riflesso di ciò che viviamo. A fronte di una visione fiduciosa e ottimista, anche il giallo metteva in rappresentazione esiti che la rispecchiassero. Guardando ai nostri giorni, lo sviluppo tecnologico non si traduce in un aumento della sicurezza ma genera crisi; inoltre, siamo sommersi da forme sostitutive del pensiero religioso, che non è più permeante come in passato, basti pensare al proliferare di paranoie dietrologiche e complottiste. Mancano le certezze, la visione della realtà si sgretola e oggi si fa fatica a pensare all’eroe tutto d’un pezzo, come quelli che popolavano l’immaginario fino a qualche tempo fa. Abbiamo assistito piuttosto, nella contemporaneità, alla nascita di tante interessanti figure di detective a metà tra l’incubo e lo sciamano. Ci sono prodotti “vecchio stile”, penso a una miniserie come Omicidio a Easttown, ma vedo difficile un ritorno al passato, se non in chiave ironica e nostalgica.
Riguardo a quest’ultima, e pensando ai più giovani che teoricamente nostalgia non potrebbero provare, credo esista una sorta di rimpianto delle cose che non si sono vissute, nello specifico di un’epoca più ordinata, semplice, non agita solo da chi l’ha vissuta, ma anche da soggetti che non hanno ragioni biografiche culturali, concettuali, esistenziali di provarne nostalgia. Un esempio riguarda la dinamica tra i sessi: non sono pochi i giovani che si rifanno a vecchi modelli superati, stile anni Cinquanta, dove intravvedono ruoli più chiari, più senso, a fronte di una società dove sono cadute tante barriere; si tratta di scenari in diversi casi considerati preferibili anche dalla componente femminile della società.
La chiave ironica, dal canto suo, è sempre molto gradita al pubblico.
Il 15 gennaio
- 15-01-2025Cape Cassola
- 15-01-2025Bravi in lettura
- 15-01-2022Corriere della Sara
- 15-01-2021La bellezza e l’oblio
- 15-01-2021Vuoto sincronizzato
- 15-01-2020Sgarbi clamorosi
- 15-01-2018Giochiamo in C.A.Sa.
- 15-01-2014“Basta giocare in difesa, ora passo all'attacco”
- 15-01-2014Taglio tribunali, bocciato il referendum
- 15-01-2014Duello all'arma bianca
- 15-01-2013Dalla Sicilia in visita al Consorzio “Brenta”
- 15-01-2013E Rosanna va all'attacco
- 15-01-2013A cena con la legalità
- 15-01-2010Torri di Portoghesi: delibera annullata
- 15-01-2010Gli strani “cerchi nel deserto”
Più visti
Politica
12-01-2026
«Narrazioni da romanzo e visibilità personale»: esplode il caso Polizia Locale
Visto 7.199 volte
Geopolitica
05-01-2026
La Danimarca acquista missili dagli Stati Uniti nonostante le pretese di Trump sulla Groenlandia
Visto 10.142 volte
Geopolitica
22-12-2025
L’India beneficia della guerra in Ucraina acquistando petrolio russo a prezzi scontati
Visto 9.586 volte
Geopolitica
29-12-2025
Pyongyang potenzia le operazioni di pirateria informatica legate alle criptovalute
Visto 9.264 volte